È circa il 2010 e da un mese vago per il Marocco con G. Ora siamo a Tangeri.
Città che fu fenicia, cartaginese, romana, vandala, bizantina, araba, portoghese, spagnola, britannica, internazionale, marocchina. Soglia magica. Moschee, sinagoghe; cinema chiusi. Edifici fatiscenti e smembrati, brulichio di vita. Al tavolino di un bar due uomini sulla settantina indossano il Kamis e bevono tè alla menta mentre preparano una canna e chiacchierano. Gli chiediamo di parlarci della loro città. Dicono solo “Ah, les années ’60 à Tanger…!”, con sognante malinconia.
Stiamo cercando un teatro. Ci lasciamo alle spalle il suq, il Grande Socco e l’eco di Bismillah au nom d’Allah, una canzone religiosa per bambini che risuona ininterrottamente dai carrelli di tutti gli ambulanti della piazza. Superiamo la libreria Les Insolites a cui già ci siamo affezionate ieri. Il libraio, Hisham Gardaf, è un ventireenne fotografo che poi rincontrerò a Parigi e Londra anni dopo. Ci ha offerto un caffè e accompagnate per le “sue” strade della città, quelle polverose dell’infanzia o quelle che dall’alto mostrano i tetti bianchi e il mare e Gibilterra lontana. Ora Hisham ci indica, oltre la libreria, una strada piena di erbacce e spazzatura che pare disabitata. È lì il teatro, dice, ma non c’è niente.
Il cancello in ferro alto e rosso, verniciato male e, dietro, una collinetta di prato secco e giallo circondano il fatiscente Teatro Cervantes. Resta solo l’insegna liberty con le lettere in stampatello blu e la cornice floreale. C’è anche la data, un fastoso 1913. È lì da 100 anni e a vederlo pare abbandonato da poco meno. Il Marocco non lo ristruttura perché è ancora di proprietà spagnola e la Spagna non se ne cura perché è in Marocco.
Sembra un castello stregato, vuoto, gonfio, pare respiri. Mi accosto al cancello, spingo e scopro che è aperto. Ci brillano gli occhi. Ci guardiamo intorno, non c’è nessuno, entriamo. Camminiamo fra l’erba arida e dimenticata e circumnavighiamo l’edificio.
Sssh! Voci.
Voci rarefatte, paiono venire da sotto, dalle cantine, dalle viscere del teatro. Lontanissime, attutite. Entrambe, io e G, abbiamo l’impressione di sentirle ed entrambe sospettiamo le nostre orecchie ingannate dall’incanto del luogo.
Torniamo davanti alla facciata, mi avvicino al portone ed è aperto. Sorridiamo, entriamo silenziose e caute. Non c’è nulla. Il foyer, quella che doveva essere la biglietteria: solo cemento spoglio. Buio. Un rumore, e intravediamo una persona di spalle che sembra stia pisciando in un angolo di uno stanzino senza porta, ugualmente spoglio. Forse ci dovremmo spaventare e invece restiamo lì, ferme, a prendere confidenza con l’aria vuota. L’uomo ci raggiunge e ci guarda interrogativo.
Vivi qui? Lo chiediamo in francese ma non risponde. Lo chiediamo anche in spagnolo, poi in inglese, in italiano. Non risponde. Però si allontana di qualche metro e tende le braccia verso l’oscurità del soffitto altissimo. Ora ha in mano una lampadina attaccata a un filo. È un filo lungo lungo che a vederlo sembra di corda ma dev’essere un conduttore di elettricità perché la lampadina si accende e l’uomo, silenzioso e pelato e giovane sotto la felpa scura, ci fa segno di seguirlo. Lo seguiamo. In fondo a sinistra c’è una rampa di scale, saliamo dietro di lui e ci ritroviamo nella platea del teatro. Molte file di poltrone ancora al loro posto e poi altre un po’ scardinate e altre ancora completamente divelte e ammucchiate, capovolte, e poi laggiù il palco con sopra una montagna di sedie spezzate. Le guardiamo come se fossero gli attori. Qualcuno mi aveva detto che una sedia su un palco è già una commedia e una sedia con una gamba spezzata è già una tragedia. Ora abbiamo davanti un secolo di tragedie accatastate. Tutto è assopito da un antico velo di polvere, ma sembra che basterebbe soffiarlo via perché ogni cosa, a cominciare dalle sedie, riprendesse vita.
Sopra di noi entra un filo di luce dalla base frantumata di una cupola.
L’uomo ci fa ancora segno di seguirlo e noi ancora lo seguiamo su per la scalinata di pietra e poi usciamo rivedere le nuvole sopra Tangeri. Sbuchiamo sul tetto terrazzato che dà sulla facciata. Guardiamo la città dall’alto. Una porticina di legno sbrindellato condurrebbe nell’interno della cupola. Facciamo per entrare ma lui ci ferma. Scuote molto la testa e a gesti ci fa capire che crolleremmo di sotto. D’accordo, ci limitiamo a fare capolino con la testa. Forse crollerebbe tutto il teatro con noi, si sbriciolerebbe sotto il rumore dei nostri passi.
Proviamo a chiedere un’altra volta alla nostra guida se viva lì, se ci abiti altra gente, da dove venga, ma lui si limita a scuotere la testa o annuire, in un modo che non ci fa suppore mai che abbia capito le nostre domande.
Lo seguiamo di nuovo giù per le scale, sempre accompagnati dalla lampadina col suo filo lungo – lungo dal foyer fino alla cima della cupola, sempre morbido, potrebbe non finire mai, forse è infinito.
Arrivati al punto di partenza vediamo una scalinata che scende sottoterra, la indichiamo ma lui pare non accorgersene. Guardiamo con desiderio e rassegnazione il mistero di quei sotterranei, cercando di carpirlo con gli occhi come i due settantenni tentavano di riappropriarsi dei loro anni ’60 solo evocandoli.
Salutiamo. L’uomo muto ci sorride.
Uscendo, ci pare ancora che dal ventre del teatro vengano bisbigli di scalognati e forse noi siamo i giganti della montagna mentre riaccostando il cancello di ferro rosso scivoliamo fuori dalla magia sospesa del teatro spagnolo e rimettiamo piede nell’incanto di Tangeri fenicia, cartaginese, romana, vandala, bizantina, araba, portoghese, spagnola, britannica, internazionale, marocchina.


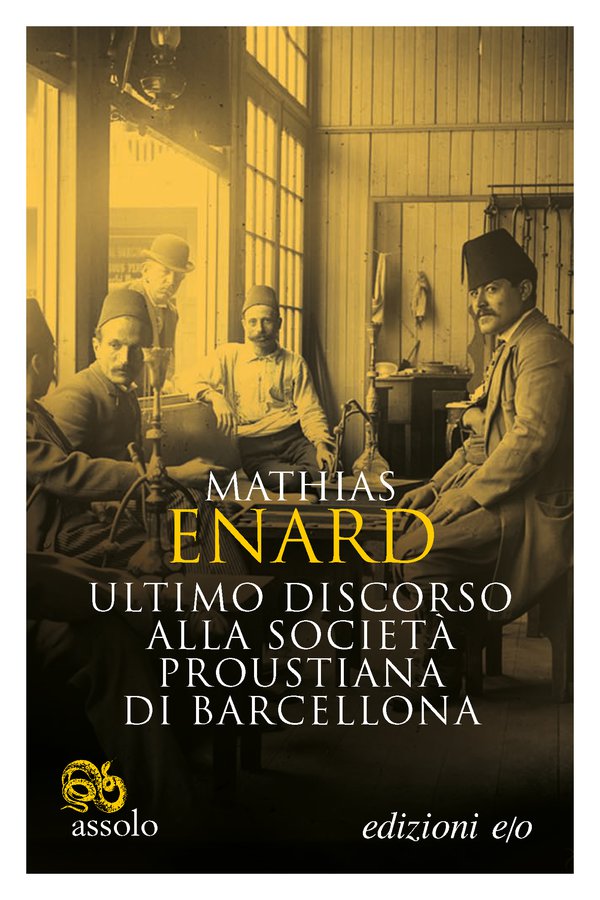
 e
e 