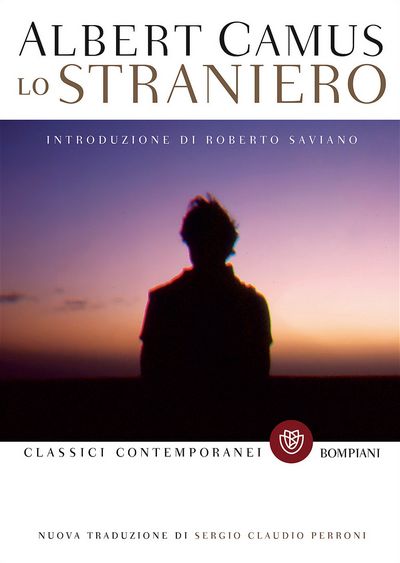La casa dove sono cresciuto traboccava di libri. Ce n’erano dappertutto: in sala, nella mia camera e in quella di mio fratello, in corridoio, nella stanza dei miei genitori. Persino in bagno c’era una piccola libreria. In garage i volumi dimenticati giacevano accatastati in improbabili colonne, ricoperti da un velo di cellophane, che non aveva impedito però all’umidità di gonfiare le pagine e ai topi di rosicchiare gli angoli di quelli lasciati più in basso. Laggiù c’erano i libri degli anni passati di scuola, i Topolino che mio fratello aveva provato a collezionare per un breve periodo ma di cui altrettanto velocemente aveva avvertito l’urgenza di nascondere; i testi universitari dei miei genitori, le copie di alcuni improponibili titoli selezionati da Euroclub e spediti al nostro indirizzo.
I miei genitori erano insegnanti. La camera di mio fratello era quella dedicata ai libri omaggio, alle varie antologie di Storia e di Letteratura Italiana. C’era uno scaffale solo per le copie della Divina Commedia, tutte tranne quella illustrata da Gustave Doré, l’unica che forse avrebbe potuto attrarre i miei occhi di bambino. La mia stanza era per la letteratura russa e quella americana. In sala la grande Letteratura Italiana, i francesi, gli inglesi. In corridoio le varie enciclopedie e i volumi di Storia dell’arte.
Da bambino odiavo tutti quei libri. Forse perché non era possibile non vederne uno in un qualsiasi angolo della casa, o forse perché ero convinto che era per colpa loro se non potevamo avere anche noi, com’era per i miei compagni di classe, un televisore a colori. Oppure perché a casa, alla fine, si parlava sempre di libri. Di libri e di scuola. Di scuola e di cultura. I miei genitori, oltre ad essere insegnanti, erano accaniti lettori. O magari odiavo tutti quei libri perché pensavo che proprio da lì partisse la rabbia dei miei di fronte a tutte le altre categorie sociali considerate meno importanti rispetto alla loro ma con stipendi assai più alti. Era uno scandalo, allora, che il fabbro guidasse una Mercedes, che l’idraulico si fosse fatto la villa in campagna con la piscina. La cultura, figlio mio, non paga. Tienilo bene a mente.
Tutti quei libri erano un dovere, e se ne stavano nascosti come una sorta di minaccia. Non avrei mai potuto leggerli tutti. Mai. Non mi sarebbe mai interessato Manzoni e la sua Storia della colonna infame. E nemmeno Il dialogo sopra la nobiltà di Giuseppe Parini. Al massimo La secchia rapita di Tassoni, o i Sonetti di Giuseppe Gioachino Belli.
Mi ricordo però che una sera, all’improvviso, cambiai idea. Una di quelle sere d’inverno con l’odore di minestra in ogni stanza e il freddo che aspettava fuori le finestre. Stavo cercando qualcosa nella libreria della sala (non ricordo cosa, magari le Divina Commedia illustrata da Doré che non avevamo mai avuto) e un libro mi cadde sulle ginocchia. Un libro di poche pagine, dalla copertina nera che inquadrava un disegno astratto con colori accesi. Lo aprii e lessi le prime righe:
«Oggi la mamma è morta. O forse ieri, non so. Ho ricevuto un telegramma dall’ospizio: “Madre deceduta. Funerali domani. Distinti saluti.” Questo non dice nulla: è stato forse ieri».
Era Lo straniero di Albert Camus. Libro che, ovviamente, avendo avuto dodici o tredici anni, non potevo conoscere. Non sapevo chi fosse Camus, non sapevo che avesse vinto il Nobel per la letteratura, non sapevo niente. Però in quelle poche righe era concentrata una vita intera. Continuai a leggere allora, frase dopo frase, restando in ginocchio in sala. Era scattato qualcosa. Un amore, o qualcosa di molto simile ad esso. Una dipendenza, forse. E dunque, nell’arco di due o tre pagine di lettura, ogni cosa era diventata superflua. Era superfluo il dover andare a cena, superfluo dover finire i compiti per il giorno successivo, superflua la nostra televisione in bianco e nero. Il dover a tutti i costi dormire quando c’era qualcosa di così bello da leggere, qualcosa che finalmente mi riempiva l’anima e i pensieri. E quelle pagine erano così lontane dalle lezioni di letteratura a scuola, dagli sproloqui dei nostri professori, dai discorsi che si faceva a tavola, a casa. Così lontano dalla retorica dei libri che ci imponevano da ragazzi.
Per i giorni successivi la lettura de Lo straniero divenne una questione totalizzante. Non c’era altro posto se non per la storia che stava raccontando il signor Meursault. Una storia assurda e straniante.
All’improvviso, per un’azione così piccola e per puro caso, tutto era cambiato. Era cambiato il mio modo di guardare i libri in casa. Non li odiavo più, quei maledetti oggetti che accumulavano polvere. Nemmeno i libri giù in garage. Nemmeno i reietti, nemmeno loro. Non era più colpa di nessuno e di niente se non avevamo uno schermo a colori. E non erano più responsabili di nulla: non dei discorsi che facevamo a tavola, non della poca competenza dei miei insegnanti, incapaci di comunicare la passione per la lettura.
Erano solo libri. Libri in cui avrei trovato altre storie. Libri che mi avrebbero rapito, o annoiato. Oggetti magici in grado di riscattare, all’improvviso, una vita intera.