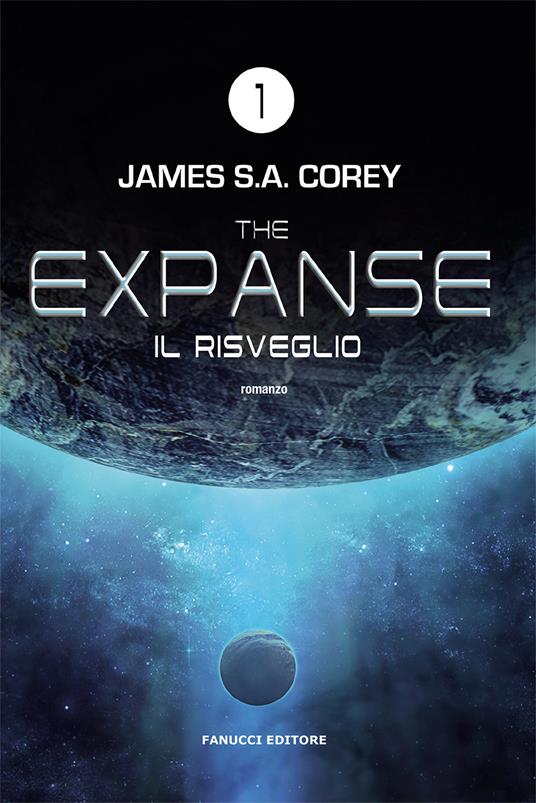Ero piccola, molto piccola, la prima volta che alzai gli occhi verso il cielo notturno. Pare un secolo fa, eppure saranno passati al massimo quarant’anni. Ma ai miei tempi, come sogliono dire gli anziani (quelli veri, intendo, non io che di anni ne ho quarantasei), non era ancora così difficile vederle davvero, le stelle, vederne tante, perché l’inquinamento luminoso era più contenuto, i lampioni più tenui, i luoghi senza illuminazione pubblica più comuni, soprattutto in Ungheria. E quindi guardai per la prima volta con un interesse nuovo quei luccicanti puntini luminosi, chiedendomi cosa fossero, quanto distassero da me, come mai ogni tanto uno sembrasse “cadere” lasciandosi alle spalle una brevissima scia luminosa; perché ce ne fossero alcuni che sembravano tremolare, mentre altri erano così tenui da essere visibili solo con la coda dell’occhio, ai margini del campo visivo. Imparai, grazie ai miei genitori, a riconoscere velocemente la Stella Polare e la costellazione dell’Orsa Maggiore. E tutte quelle stelle dai nomi evocativi: Antares, Rigel, Betelgeuse, Altair, Eta Carinae. Mi regalarono un’enciclopedia dell’astronomia dalla quale imparai molte cose sul cosmo, alimentando una vera e propria fascinazione per lo spazio prima e la fantascienza poi. Una volta, avrò avuto forse quindici anni, sono sicura di avere visto un UFO, almeno nel senso di “oggetto volante non identificato”. Ma casomai di questo parlerò un’altra volta. Molti anni più tardi, su una spiaggia in Western Australia, avrei visto la Croce del Sud, punto di riferimento celeste per l’emisfero australe, e la Nube di Magellano, così, a occhio nudo. La Via Lattea, in quella notte straordinariamente tersa, rischiarata solo dalla delicata fosforescenza del plancton sulla superficie dell’oceano, era un nastro opalescente che attraversava la volta celeste, luminosissima, incredibile. Non l’ho mai più rivista così.
Ricordo molto bene anche il dolore tremendo nel vedere esplodere in diretta il Challenger – nel 1986: avevo undici anni – e nell’assistere al rientro fatale del Columbia (nel 2003). Eppure, anche quelle tragedie non mi hanno mai tolto la voglia di capire meglio il cosmo, perfino di sognare di poterlo esplorare. Forse è per questo che tra tutti i tipi di fantascienza apprezzo soprattutto quella che parla di un futuro sufficientemente prossimo da essere ancora comprensibile con metriche “umane”, con macchine volanti, esplorazioni di altri pianeti e la costante frustrazione del tempo, inesorabilmente breve delle nostre vite, implacabilmente lungo per le distanze da percorrere, come ostacolo tra noi e l’immensità del cosmo.
Immaginiamoci, allora, un futuro non troppo recondito in cui gli umani hanno raggiunto Marte e stanno procedendo con il terraforming del pianeta da generazioni, anche se al momento i marziani vivono al chiuso, in strutture sotterranee o comunque coperte. I marziani sono fortemente militarizzati, vivono con abnegazione il loro sforzo di rendere il pianeta rosso davvero abitabile (anche perché, se non coltivassero l’orgoglio di essere marziani, non si capisce chi glielo farebbe fare, di vivere in mezzo alla polvere rossa del pianeta); generalmente disprezzano, in maniera non troppo nascosta, i terrestri, che giudicano gente debole e viziata. Immaginiamoci una Terra sovrappopolata, esausta, svuotata di risorse, abitata da troppe persone che, peraltro, di fronte all’allargamento degli orizzonti umani, continuano incomprensibilmente a sentirsi un’élite: i “veri umani”, i terrestri. Immaginiamoci, infine, anche un terzo mondo, schiacciato tra i due poli terrestre e marziano: ecco i cinturiani, povera gente nata e cresciuta in assenza di gravità sulle colonie costruite nella Cintura di Asteroidi, tra le orbite di Marte e Giove. I cinturiani sono considerati la feccia dell’umanità, poveracci disorganizzati da sfruttare, il cui benessere è ampiamente subordinato al guadagno di entrambe le superpotenze. In questo tutti-contro-tutti che si esprime tramite ostilità diffusa, sfiducia, episodi sparsi di intolleranza, oscure trame politiche, aggiungiamo infine due elementi: un equipaggio misto (umani, marziani, cinturiani), che convive destando a sua volta sospetti in chi incontra il suo vascello, battezzato Rocinante (in italiano Ronzinante, il cavallo di Don Chisciotte nel romanzo di Cervantes), e lo xénos, l’alieno in una delle sue forme più terrificanti: non un mostro, ma una molecola ignota, imprevedibile, apparentemente potente e incontrollabile, con un’agenda talmente lontana da quella degli esseri umani da considerare questi ultimi al massimo come dei moscerini irrilevanti. Un’alterità con la quale non ha senso misurarsi secondo intenzioni o volontà umane, che quindi non è facilmente identificabile né come ostile né come amichevole, semplicemente perché i suoi movimenti si misurano su una scala infinitamente volte più grande, duratura e complessa dell’umanità intera.
In questo scenario politicamente e socialmente turbolento, nel quale una delle vie per la salvezza sembra celarsi ancora una volta in un’alleanza universale, che vada oltre le differenze di vedute, si muovono i nove libri della saga di The Expanse. Lo so, lo so, c’è anche la serie televisiva, bellissima e consigliatissima pure lei, ma i libri, per me, hanno sempre il pregio di permettere a chi legge di immaginarsi luoghi, ambientazioni, facce, reazioni, corpi, tatuaggi, odori e sapori. I libri non hanno problemi di budget per gli effetti speciali, e possono permettersi di abbracciare la lunghezza di una vita umana e oltre senza il problema di dover invecchiare i personaggi, giusto per citare un esempio.
La fantascienza di The Expanse è tangibile, sporca di grasso per motori, fatta di affetti spezzati, di paure, di frustrazioni irrisolte, di muscoli atrofizzati per l’assenza di gravità; di potere, esibito sin dagli abiti indossati, di guadagni, di scoperte scientifiche, di battaglie che si consumano nel silenzio dello spazio interplanetario, di malattia, di desideri, di amore (eterosessuale, omosessuale, poliamoroso, sfaccettato) che sopravvive anche alle distanze più grandi; di occhi alzati al cielo, come i miei quella volta di tanti anni fa, e di persone che forse con più convinzione di me hanno coltivato il sogno di solcare personalmente quell’immensità seducente.