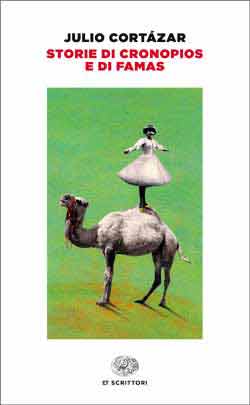Ho dedicato cinque anni della mia vita alla letteratura prodotta in Argentina sulla guerra delle Malvinas-Falkland: i due anni in più rispetto a quelli che l’Università richiede li ho spesi a cercare di comprendere la logica di quella guerra. Probabilmente come accade con ogni guerra la capiremo tra qualche anno, quando sarà possibile accedere a qualche informazione in più, oppure semplicemente il tempo farà accadere nuove cose che aggiungeranno distanza, lucidità e una casistica che non avevamo considerato.
Capire la guerra non è cosa da poco.
In questi cinque anni mi sono imbattuta in alcune storie mentre altre mi sono venute a cercare. Ho visto il conflitto da numerose angolazioni e prospettive, ho empatizzato con emozioni contrastanti, e tutto questo vedere e sentire mi aiuta oggi ad avvicinarmi al paradosso di questa guerra con qualche strumento in più. Il paradosso, se posso provare a sintetizzarlo, sta in un’affermazione di Martín Kohan, scrittore e docente universitario: “La guerra delle Malvinas è stato l’ultimo episodio della dittatura. Dobbiamo ringraziare di averla persa, altrimenti chissà quanti anni ancora sarebbe durato il regime militare”.
La storia di Silvia mi è venuta a cercare.
Silvia mi dà appuntamento a una fiera delle orchidee che pare si tenga ogni anno in un grande salone adiacente a una chiesa in uno dei quartieri a sud di Buenos Aires. So di lei che è una donna con una formazione militare, molto cattolica, che ha un marito buddista e che da poco ha iniziato ad appassionarsi alla naturopatia e prescrivere fiori di Bach. È Infermiera Capo nell’ospedale della Marina Militare di Buenos Aires e lo era a Bahía Blanca nel 1982.
Penso come prima cosa che le chiederò di parlarmi del “piede di trincea”, una cancrena ai piedi che colpiva i soldati che combattevano guerre di frontiera in zone fredde, della quale non c’è più traccia nei documenti di guerra europei dalla fine della campagna in Russia. Non l’avevamo curata, avevamo banalmente capito che i soldati dovevano andare in guerra con un equipaggiamento adeguato, mentre invece capitava, durante la guerra dell’82, che i coscritti che partivano dal nord equatoriale dell’Argentina non fossero dotati di anfibi ma di scarpe di tela. Invece no, Silvia non mi lascia spazio.
Facciamo un giro tra le orchidee, lei mi spiega delle diverse famiglie, di come si ottengono innesti migliori. Io annuisco. Ammira, e ammiro anche io con lei, pareti intere piene di orchidee rampicanti. Mi regala un fiore e mi chiede di andare a prendere un caffè. Ci sediamo in un bar pieno di marmi in questo caldissimo giorno di ottobre del 2014 e mi chiede aiuto. Chiede aiuto, lei a me, perché, dice, non ha gli strumenti per raccontare la sua storia. Silvia nell’aprile dell’82 era a capo delle infermiere dell’Ospedale della Marina Militare di Bahía Blanca, si era formata con l’addestramento militare e con gli studi medici e aveva seguito il percorso di tantissime giovani donne come lei. Aveva trent’anni. Un giorno il suo capo decide di affidarle una missione: trasformare una nave rompighiaccio in un ospedale galleggiante perché il numero dei feriti della guerra inizia a crescere e loro non sanno come fare a portarli sul Continente, non ci sono i mezzi sufficienti perché raggiungano in tempo il loro ospedale, che è il più vicino.
Silvia si rimbocca le maniche e seleziona un gruppo di infermiere. “Per sette giorni abbiamo seguito l’addestramento militare di giorno e trasformato la nave di notte, senza dormire, senza fermarci. Il tempo era il nostro unico nemico”. Mi racconta che non credeva che trenta donne potessero avere una forza tale da scardinare portelloni di acciaio pesantissimo per cambiare l’assetto della nave, per ricavare delle sale chirurgiche. Mi racconta tutti gli sforzi fatti, la sensazione fisica della fatica che sentivano addosso e dell’adrenalina che le spingeva a non fermarsi. Mi racconta che l’ossessione di tutte era quella di salvare delle vite: quella era la loro missione.
Dopo sette giorni Silvia e le sue ventinove infermiere, militari e civili, erano pronte a salire su quella nave per raggiungere le isole – isole che sono rappresentazione, nell’universo simbolico culturale argentino, di qualcosa di perduto e irraggiungibile – ma il suo Capo le comunica il contrordine: nessuna di loro salirà sulla nave, partiranno trenta uomini al loro posto, e aggiunge – questo Silvia ci tiene a sottolinearlo con lo sguardo di chi intende “me lo ricordo come se stesse accadendo adesso” – “Siete delle donne, pensavate davvero di poter fare la guerra?”.
Mentre io resto impietrita Silvia fa una cosa che non riesco a tollerare: inizia un pianto che è in realtà un riflesso involontario. Piange solo perché le lacrime spontaneamente le scorrono sul viso e lei le asciuga quando arrivano al termine della corsa. Per il resto non tradisce emozione – io no, io sono arrabbiata.
Silvia aggiunge elementi alla narrazione: mi racconta di quant’è stato difficile dirlo alle sue infermiere o meglio che il difficile è stato fare in modo che non si sentissero abbandonate da lei e che mollassero. Parliamo sempre di trenta donne scelte per lavorare nell’ospedale più vicino alle isole, che dovevano rimanere lucide e che di lì a pochissimo avrebbero accolto, accudito e curato dei giovani coscritti incapaci di fare la guerra, ragazzi che sarebbero potuti essere i loro fratelli o i loro fidanzati. Mi racconta poi di alcuni casi critici o di soldati che avevano salvato e con cui ancora è in contatto, del piede di trincea e dei casi di denutrizione. Fa una cosa mentre racconta che un po’ mi solleva: sottolinea in più occasioni che i soldati feriti che arrivavano all’ospedale non li portava “quella” nave. Quella nave sparisce dal nostro orizzonte. Alla fine del racconto Silvia è ancora serafica – devono esser stati gli anni nell’Ospedale della Marina Militare a farle mantenere questo controllo – ma aggiunge l’ultimo pezzo della storia: negli ultimi anni è riuscita a raggiungere le ventinove donne, che nel frattempo hanno lasciato la Marina e in alcuni casi anche il paese, per raccogliere il loro ricordo di questa vicenda in un documento ufficiale che le servisse per richiedere ai propri superiori che il loro impegno durante la guerra venisse riconosciuto.
Silvia è una donna testarda, una di quelle che sanno fare la scelta giusta. Il 14 novembre del 2014 mi trovo insieme a queste trenta donne e alle loro famiglie all’interno della Sala d’Onore del palazzo della Marina Militare a Buenos Aires. Silvia è riuscita a ottenere una cerimonia ufficiale, un gesto simbolico che cura, in cui gli alti ranghi della marina – formati esclusivamente da uomini – possano rendere omaggio a queste donne.
A Silvia non serviva il mio aiuto, le mancava un pezzetto di coraggio e di rabbia. A questa storia serviva il tempo.