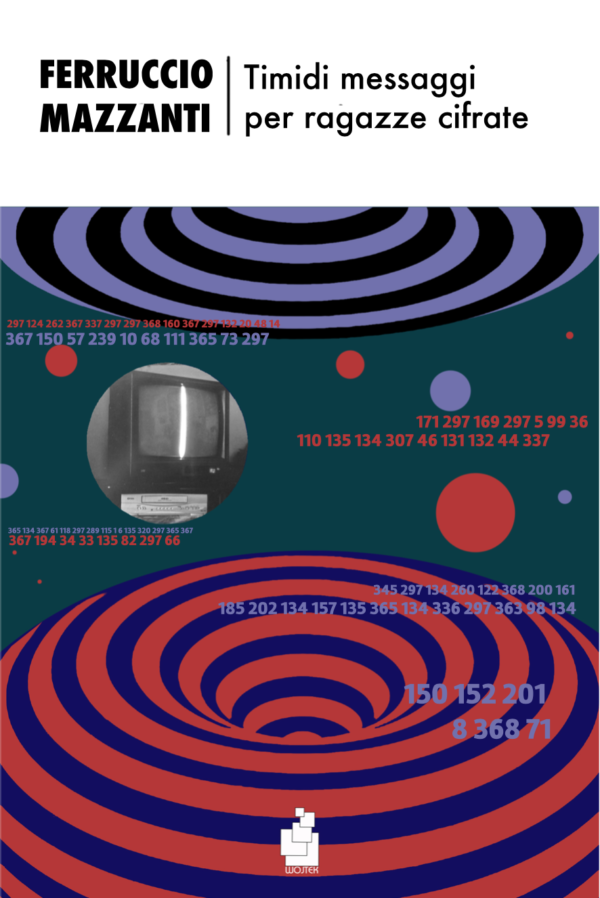Se continui ad amarmi per un ricordo significa: duecentosessantotto giorni e quaranta minuti, e poi altalene, rincorse, aeroplani in cucina, desideri da soddisfare e a cui rinunciare, altri letti da rifare, sabati pomeriggio passati fuori, avena bagnata di latte, compleanni inosservati, cloro sulla pelle, addormentarsi abbracciati sul divano, barzellette dette senza guardarsi negli occhi, ricreazioni interrotte, parole che si possono non dire. Poi ancora trecentodue giorni e altri minuti da sommare.
Se continuo ad amarti per un ricordo significa: abbandonare giornate intere. Rincorrere umori diversi, sorrisi diversi, sfondi diversi. Ritrovarti all’inizio, davanti a una macchia sul tappeto, a un odio che a volte cresce come la curiosità, a improvvisate partite a tennis durante colazione. Tornare a casa e cercare la tua guancia e tu, nascosta chissà dove, in attesa di essere scoperta per mostrarmi come un abbraccio possa nascondersi dietro a un divano, sotto a un letto, accanto a una pubblicità di un film in prima serata, tra un frigorifero aperto e un calendario con il mese sbagliato.
Se mi dici «Tranquillo, sto bene, non ho niente» significa: «Non ti rendi conto di che cosa c’è là fuori, al di là delle persiane, giusto due rampe di scale da noi? C’è un mostro che non si ferma mai ed è orribile».
«Non ti preoccupare, mi ricordo tutto. Il corridoio. L’umidificatore a forma di girasole al termosifone del salotto. Il battiscopa staccato a destra della porta di cucina. Il tuo viso. Come porti i capelli adesso?».
«Vedo: un uomo seduto sulla panchina. Una lattina che sta per cadere dal cestino. Il forno della signora Carla in fondo alla strada. Una donna in tailleur che cammina in un corridoio nel palazzo di fronte, porta a spasso dei fogli. Un’antenna che sembra l’albero di una nave».
Se ti dico «Tranquilla, sto bene, non ho niente», significa: una mattina di inizio agosto in cui ho alzato le mani su mia cugina perché aveva pestato, volontariamente o no, uno dei miei giocattoli preferiti. Due ragazzini che rincorrono una lucertola con il getto della loro pipì, tanti anni fa, in campagna, tra l’erba bruciata dal sole e il cemento. Le mani di mia nonna che devono portare un bicchiere d’acqua alle labbra. Fabio che mi confida di volersene andare ma senza sapere dove. Tu che ti alzi e te ne vai e non mi guardi. Una falena che continua, e continua, a sbattere contro una luce. Una porta sempre chiusa.
Se lasci la testa dello spazzolino a sinistra significa: quella domenica sera che sei tornata a casa lasciandoti alle spalle bolle di sapone. Quando abbiamo fumato insieme la prima sigaretta, senza farci vedere, senza sapere da chi, o da cosa, ci stessimo nascondendo. Quanto desideri imparare a fischiare. Che ancora ci sono domande che vorresti farmi, parole che vorresti sentirmi dire. In mezzo c’è solo una maniglia, una soglia, tre, quattro passi, e tutto il resto.
Se lascio la testa dello spazzolino a destra significa: sono ancora qui. Ti aspetto.
Se guardi le luci della notte fuori dalla finestra significa: una strada, un quartiere, una città, un’intera regione. Pensarli tutti e rallentare per pensarli bene. Non muoversi per pensarli felici.
Se guardo le luci della notte fuori dalla finestra significa: cambiare significato ai lampioni, ai fari delle macchine, alle insegne degli hotel, alle luci delle case, alle intermittenze rosse e bianche degli aerei nel cielo; farli diventare mesi, settimane, giorni, minuti.
Se appoggi il palmo della mano sulla superficie interna della porta significa: accarezzare una separazione, dello stesso spessore di uno strato di legno con le sue venature dritte frutto di un taglio parallelo all’asse del tronco. Ridurre il dolore a semplici materiali, come toccare un addio solo dall’esile profilo di una cartolina.
Se appoggio il palmo della mano sulla superficie esterna della porta significa: esci, ti prego. Apri questa porta. Ho bisogno di te, mamma!