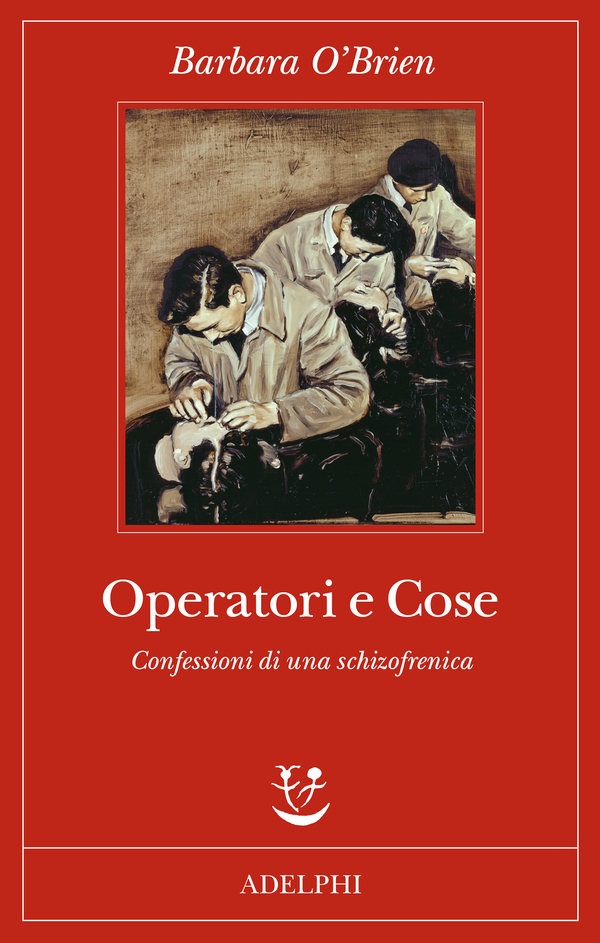Davanti alla malattia mentale abbiamo spesso reazioni amplificate e refrattarie: è dimensione che ci interpella giocoforza ma che ci spaventa, che ci è più facile in fondo tenere a distanza, come un territorio inaccessibile, che non si può esplorare, che può essere indagato da esperti competenti i cui resoconti non arrivino però a toccare le nostre sensibilità, a minacciare il nostro supposto buon equilibrio psicologico. Non è così: nelle sue diverse forme – nevrotiche o psicotiche, più e meno gravi – il disturbo della personalità ci riguarda. Come che sia ci interpella, perché di abissi sui quali la nostra mente potrebbe affacciarsi, e molte volte è a un passo dal farlo, e altre volte lo fa, la vita è costellata. Ricordo sempre l’impressione profondissima che fece su di me lettrice adolescente il libro di Patricia Highsmith Diario di Edith, pagine che nel disturbo della personalità si addentravano “senza filtri”, mostrando quel crinale sottile, impercettibile e terribile lungo il quale si trova a scivolare, glissando verso territori impervi e oscuri di instabilità, qualcuno che invece pensi sé stesso come inserito nella più completa normalità.
Qualcosa di simile, identica impressione profonda e perturbante, ha sortito di recente su di me lettrice un libro che Adelphi traduce a molti decenni di distanza dall’uscita negli Stati Uniti (1958, con una seconda edizione postillata nel 1976), Operatori e Cose. Confessioni di una schizofrenica. Dell’autrice, Barbara O’Brien, si sa pochissimo, a parte la menzione di una sua avvenuta guarigione. E questa aura di quasi anonimato rende criptico ma anche molto potente un testo che non si limita a essere, come recita il sottotitolo, “cronaca” di una patologia schizofrenica, ma che inserisce la dinamica psichica in uno schema di rapporti di forza a sua volta simbolico della società intera.
“Operatori” sono gli addetti alla cura, violenti nella loro manipolazione psicologica dei malati mentali: entità invisibili che orientano persone, fatti, lo stesso disturbo mentale. “Cose” per converso sono i malati, manovrati da quanti pretendano di portar conforto e che di fatto invece chiedono loro di abbandonare personalità e manìe per adeguarsi a un sistema. Del disturbo psichico, pensato perciò in senso politico, O’ Brien offre definizioni nitide e taglienti. “Rinunciare all’interezza per ottenere l’accettazione di una parte di sé è, credo, la tragedia dello schizofrenico, che non riesce a essere sé stesso e chiede al suo ambiente di accettarlo”. O ancora: “quante parti di te stesso sotterri nel processo di maturazione, per adattarti alla società? Ti seppellisci per metà? Per un quarto? Per settori?”.
“Un romanzo è fatto dei suoi territori” l’autrice scrive, ed è effettivamente una cosmogonia quella che disegna e fa splendere le sue pagine. Su sponde opposte, secondo uno schema un po’ alla Orwell, “Operatori” e “Cose” si fronteggiano, opposti sebbene accomunati da un territorio intermedio fatto di intuito, immediatezza, sensitività e denominato “Qualcosa”. Viene così a disegnarsi una geografia del malessere, astratta e disincarnata al pari dei contorti arcipelaghi cui dà forma. Uno spazio vasto e scisso in modo crudele, i cui attori non hanno volto, agiscono soltanto, e nel loro agire feriscono le psicologie o ne sono psicologicamente feriti. Una distopia che stravolge il nostro modo abituale di considerare la follia, alterando in primo luogo lo sguardo che la persona mentalmente disturbata rivolge su sé stessa. “Non solo vivo in gabbia”, la semi-anonima autrice racconta del suo ricovero psichiatrico, “ma è una gabbia deformata. Mi costringe a vivere in un mondo doppio. È come avere uno specchio magico in cui osservo quello che succede sulla luna mentre devo continuare a cavarmela qui sulla terra”.
Operatori e Cose è un libro magmatico e potente, che aiuta a pensare la malattia mentale con autonomia, lontano dai clichés. Tremiamo con lei, la paziente “cosa”; con lei ci indigniamo per le costrizioni cui viene sottoposta, con lei vibriamo l’angoscia di un anonimato che è spersonalizzazione (“questa qua”, così la stessa O’Brien si definisce). Ed è grazie alla forza di un testo del genere che una volta di più avvertiamo come la normalità sia territorio definito da un limite sottilissimo, varcare il quale è un attimo. Un attimo portatore di emozioni e gravido di vera letteratura.