Ho sempre avuto la mania di osservare le persone; soprattutto quando sono sole.
Ho sempre avuto l’idea che, da sole, le persone esprimano con più intensità la loro essenza. Come ordinano una spremuta, come si riavviano i capelli. Come gesticolano al telefono, come sbattono i tacchi per il nervosismo – aspettano qualcuno, devo approfittare del momento per indagare bene. Come si accendono una sigaretta. Come sbuffano il fumo – se lo godono o si sentono in colpa?
Insomma, mi sono specializzata nell’osservazione delle solitudini con l’idea di cogliere l’essenza di figure sconosciute dei cui affari non dovrei interessarmi. Sarà forse per via di questo mio chiodo fisso, se fin dall’infanzia sento una particolare simpatia per una precisa categoria di solitarie: le zitelle.
Lo so che dovrei dire single o qualcosa del genere, ma voglio invece proprio usare la parola zitella, soffiarle di dosso la polvere, voglio che sia una parola splendente che evoca scenari di divertimenti e anche, perché no, di vaga perdizione, come e più del suo equivalente maschile, scapolo, che emana un’aura un po’ démodé di dopobarba al vetiver, mentre zitella, ecco, ci dà subito l’idea di una condizione non scelta; subìta. Ma quanto è retriva questa idea, e quanto liberatorio farla a brandelli, con l’aiuto di zitelle reali e pure fittizie, personaggi sfolgoranti di arguzia che ci regala la letteratura. Jane Austen, per dire, fu un’ostinatissima zitella, determinata a rimanere fuori dagli stritolanti ingranaggi del matrimonio che all’epoca per una donna equivaleva a una corvée e le avrebbe impedito di scrivere come scrisse tutta la vita, su tavolini appartati nel chiasso delle case dei fratelli. Scoprire, da adolescente, che i suoi romanzi non erano sdolcinatezze da centellinare in un tintinnio di tazzine da tè (come erroneamente suggerivano certe brutte copertine), ma analisi sarcastiche delle asimmetrie di rapporti che iniziavano a turbarmi, mi ha aiutata a evitare che il richiamo, pur scherzoso, che mi colpiva quando ero troppo competitiva con i maschi – guarda che così rimani zitella! – suonasse mai come una minaccia.
Quella lettura è stata il lasciapassare per accedere a un mondo popolato di zitelle; buffe e formidabili come Miss Marple, pasticcione e insoddisfatte come Bridget Jones, e poi le mie preferite: le zitelle seduttive, le zitelle-dive: la zia Mame di Patrick Dennis, la galleria di ex belle del Sud che appassiscono irradiando un fascino magnetico nelle pagine delle opere teatrali di Tennessee Williams. E su tutte le possibili zitelle letterarie, la figura ieratica di uno dei personaggi più cari al mio cuore, da sempre e per sempre. Miss Havisham, la vera protagonista di Grandi speranze, la sposa che incartapecorisce dentro il vestito nuziale, viva e morta insieme: può battere un cuore spezzato? O rimane fermo come gli orologi che in tutta la casa lei ha fermato sull’ora in cui, mentre si vestiva per le nozze, una scarpa infilata e l’altra no, ha saputo di essere stata abbandonata? Per crearla Dickens pare si sia ispirato a un fatto di cronaca – la storia dell’australiana Eliza Emily Donnithorne, rifiutata dal fidanzato il giorno delle nozze, nel 1846. Lei passò i successivi quarant’anni nel buio della casa, la porta aperta perché lui potesse tornare – peccato che fosse morto poco dopo la data del matrimonio mancato.
Se davvero questa sia stata un’ispirazione per Dickens è questione dibattuta, perché – e la cosa ha del meraviglioso – Eliza Donnithorne visse un bel pezzo anche dopo la comparsa della sua omologa di carta. Quindi, pur ammettendo che abbia influenzato la nascita della terribile signorina, non è da escludere che anche sulla sua vita abbia avuto un influsso la creatura fittizia della cui ideazione lei fu (forse) involontariamente responsabile.
Mi piace pensare a questa storia, a come si aprano passaggi segreti fra la vita e la letteratura. Basta abbassare una levetta nascosta nella libreria. E la vita erompe, e le nostre solitudini di lettori si lasciano abitare dalle solitudini dei personaggi, che ci somigliano tanto, perché quando siamo soli, quando siamo liberi di essere noi, finalmente ci capiamo.


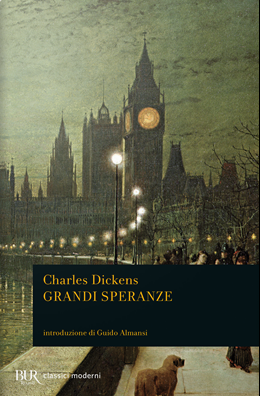
 e
e 