I miei primi libri erano le canzoni, le “leggevo” sculettando come un idiota in camera da solo.
La camera della mia infanzia era grande e spaziosa, ci ho vissuto una dozzina di vite lì dentro, tutte da solo, più o meno di pomeriggio.
Verso Natale, il rivedibile spettacolo di cui sto per farvi partecipi avveniva nell’invisibile profumo del gigantesco albero di Natale che stava fra la poltrona e la finestra. Mia madre lo “smontava” verso aprile, quello (l’albero) non voleva saperne di morire.
Avevo setto/otto anni. Facevo questa cosa, mia madre adesso se la ricorderà, immaginavo di essere un frontman di un gruppo che mi piaceva o magari un cantautore di quelli che sentivo per radio. E mi esibivo in pigiama, da solo, col mio riflesso sul vetro di un quadro sopra al divano.
Sembravo un nano uscito con la legge Basaglia.
Col senno di poi, quei live da ritardato fra i poster della Fortitudo e le immagini della Madonna che mi regalavano ai Salesiani, sono stati parecchio istruttivi.
Una cosa andava preliminarmente tenuta a mente col pigiama fradicio di sudore, ciò che accadeva in quella in quella stanza era al contempo ridicolo e drammatico.
La seconda era che se fossi mai, in futuro, stato capace di accettare che il dramma e la farsa si mischiassero nei miei giorni, sarei stato in grado di raccontare le vite degli altri.
Alla fine di una esibizione su Son sciopà di Jannacci per esempio, mi bastò seguire il mio labiale sul vetro della finestra “Tu che neghi le Marlboro forse adesso hai capito come nascono i comici” affinchè tutto quel che sto provando a dire, fosse chiaro. Perlomeno a me.
Tutto iniziò quella sera in cui a Domenica In sbucò Renato Zero in tutina aderente. In casa c’eravamo io e mia nonna, forse l’essere apparentemente più lontano dal “sorcino” tipo che possiate immaginare.
“Seguimi io sono la notte, il mistero l’ambiguità, dei desideri io sono la sorte, quell’attimo di vanità” cantava Renato mentre il piedino di mia nonna (appena tornata da Messa) teneva il tempo.
Lo guardava senza necessità di giudizio, con la stessa apprensione che provava per me: come uno per il quale temeva circa il suo futuro. “Cosa farà da grande?” sembrava domandarsi preoccupata.
Quel piedino nella scarpa da merceria che batteva il tempo con Renato mi fece sentire al cospetto di una tribù segreta che andava dalla disperata periferia romana alla piccola borghesia bolognese che fa tutto quel che può per esser presentabile senza avere nessuno a cui esser presentata.
Cos’altro mi pareva di aver intravisto? Che siamo tutti soli ma esiste la possibilità di esser “soli insieme” e se questa condizione la senti tua o canti o scrivi, non c’era molto altro da fare.
E poi le canzoni erano la prima forma di short story, forse la più formidabile, cui mi sono imbattuto.
Per esempio fu Lucio Dalla a spiegarmi che aveva ragione Cechov quando diceva che, alla fine, “… i due poli di ogni narrazione sono sempre gli stessi, lui e lei…”, e gli bastò inchiodarmi all’ascolto di Anna e Marco perché Cechov fosse soddisfatto.
“Anna avrebbe voluto morire, Marco voleva andarsene lontano, qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano”. Riuscirò mai a scrivere un romanzo infinto come quello contenuto in questa ventina di parole?
Me lo domandavo a undici anni, me lo chiedo adesso.
Per carità, non volevo uscire dal tema dello spazio che mi ospita divagando sulle canzonette, era solo per precisare che la mia “formazione” non è avvenuta attraverso i romanzi bensì i racconti brevi.
Si scrive perché si ha il tempo di farlo, cioè quando la vita non ce l’hai più.
Nessuno sano di mente si mette alla scrivania a narrare delle proprie scoreggine dell’anima, peggio ancora aggrappandole a istanze più o meno rispettabili, finché è ancora in tempo per mentire ai propri genitori, risultare ridicolo a una donna o su un campo da basket. Col tempo si diventa multitasking e in effetti ci si riesce, la morte ci vuole pettinati. Ma saper scrivere non è bel segno, credetemi.
Per quanto mi riguarda le canzonette e scrivere sono le due pratiche più intimamente connesse alla vita; le canzonette erano la mia occupazione in attesa che la vita arrivasse, scrivere è quel che si fa quando non sa più dov’è finita.
I racconti dicevamo, erano perfetti. Non sono mai stato tagliato per una cosa che inizia, si sviluppa e poi finisce. La vita funziona così ad esempio, ma non è così che si offre. La vita ci si da per dettagli, come abbracci intravisti dal finestrino di un treno.
I nostri giorni, in fondo, non sono che una manciata di Polaroid in ordine sparso.
Se provi a metterle in ordine scrivi romanzi, se ti basta guardarle i racconti andranno benissimo.
Nella mia vita Nove racconti di Salinger (L’uomo ghignante in particolare, fra questi) hanno aperto e chiuso i discorsi.
E poi Flannery O’Connor (La vita che salvi può essere la tua fu il primo che mi capitò sotto mano, si poteva chiuderla lì?) e Carver (Perché non ballate?, Legna da ardere, Grasso e tutto il resto come direbbe lui).
Credo che il libraio di via delle Moline a Bologna si sia ricordato per un bel pezzo di quel ragazzetto insistente (e francamente inchiavabile) che gli chiedeva Casa d’altri di Silvio D’Arzo.
La boutique del mistero di Buzzati mi diede il colpo di grazia.
Usavo i racconti (soprattutto quelli altrui) per rimediare alla mia pigrizia.
C’è stato un tempo in cui se dovevo dire qualcosa di importante a qualcuno regalavo Passeggeri, catalogo di motivi per vivere e volare di Gabriele Romagnoli.
Mi piaceva che quelle “fotografie” fossero scattate non solo esattamente con il taglio e la luce che avrei usato anch’io ma anche che chi aveva fatto click abitasse nella mia stessa città.
Come se il mondo potesse avere il mio stesso codice di avviamento postale.
Non credo di esser riuscito a spiegare con la dovizia che si esige da chi fa il mio mestiere perché faccio quello che faccio per vivere (tantomeno come si viva di questo vivere) quando tutto questo abbia avuto inizio e quali diverse forme abbia assunto.
Volessi tirarla per le lunghe avrei decine di altri esempi, oppure, quasi per gioco, posso lasciarvi un racconto brevissimo (quattro righe) nel quale tutto quello che ho provato a dire si mette in posa e sorride, come in una polaroid:
L’altro giorno ero in auto e per radio è arrivata John and Mary di Robert Palmer.
Mentre aspettavo che il semaforo diventasse verde ero in camera mia, lì con me c’erano i miei,
i poster dei giocatori che non sono diventato
e l’odore dell’albero di Natale che, ostinatamente, non imparò mai a morire.


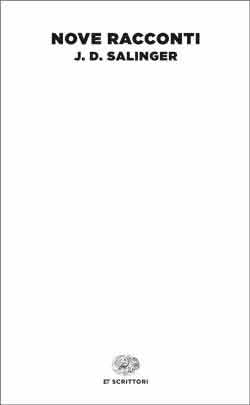
 e
e 